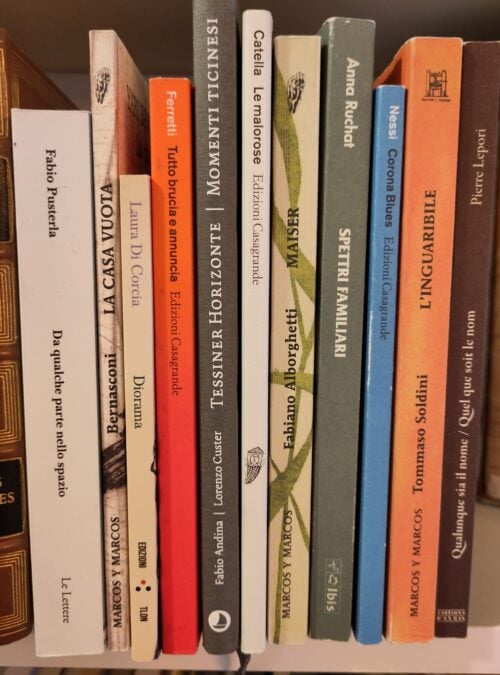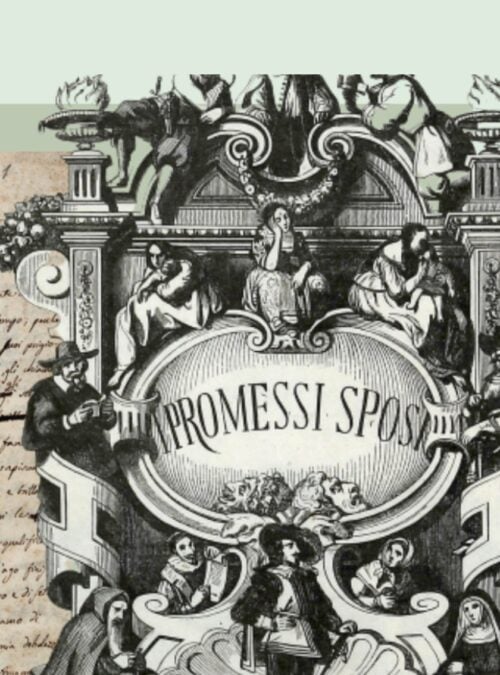Echi di Trieste nell’editoria francese (prima parte)
Autore: Laurent Feneyrou (CNRS)

Nel 1917, una delle prime traduzioni francesi di un’opera triestina, pubblicata in Svizzera e ingegnosamente firmata Tergestinus, fu Irredentismo adriatico (L’Irrédentisme adriatique), in cui il giornalista e saggista socialista Angelo Vivante si mostrava attento al compromesso e alla tutela delle autonomie balcaniche e degli interessi delle due sponde, quella italiana e quella slava. Sei anni dopo il suicidio di Vivante, la cui tendenza “quasi a-nazionale” non poteva accettare il crollo della sua utopia, Benjamin Crémieux tradusse il capolavoro di Scipio Slataper, Il mio Carso, con il titolo Mon frère, le Carso (1921), versione che fu ripubblicata lo stesso anno – il libro era stato accolto da una relativa indifferenza nel 1912, presso le edizioni della Libreria della Voce. L’autore, un pioniere, incarnava il dramma di una generazione nata negli ultimi decenni del XIX secolo e destinata al sacrificio sui campi di battaglia della Prima guerra mondiale, nel caso di Slataper, sul monte Podgora, nel 1915. Della sua città natale, questi condivideva le tensioni e le contraddizioni che la attraversavano e, si può dire, la dividevano, i suoi valori e tormenti, una certa marginalità rispetto al resto d’Italia, e la sintesi tra i riflessi azzurri dell’Adriatico e la roccia bianca del Carso, l’altopiano calcareo che si stende ai piedi delle Alpi Giulie.
Come definire allora la letteratura triestina, se non con questo volto composito, con questa “identità di confine”, come avrebbero poi scritto Angelo Ara e Claudio Magris? Tanto più che, malgrado i primi romanzi di Italo Svevo, essa emerge in esilio, a Firenze, nel 1909, sotto la penna di Slataper, appunto, sulle pagine de “La Voce”, e poi con lo splendido Piccolo canzoniere in dialetto triestino di Virgilio Giotti – quei versi pici e tristi, ma anche pieni d’amore – pubblicato in Toscana nel 1914 da Ferrante Gonnelli. Dobbiamo limitarci ai soli scrittori della città o includere, in modo più ampio, quelli della regione? Ma fino a dove? Fino ai suoi antichi confini? E dove finisce l’Italia? con l’Isonzo? a Trieste? oltre? In quel periodo di rivendicazioni, criteri nazionali e considerazioni geografiche e militari si mescolano confusamente. Essere nativo di Trieste è una condizione sufficiente per rivendicare di appartenere alla letteratura triestina? Non ce n’è forse una sola, quella di una triestinità consapevolmente resa estranea alla storia? Questa letteratura è solo l’opera di chi si esprime in italiano o in dialetto – ma che fare allora degli straordinari versi sloveni di Srečko Kosovel, anch’essi composti sul Carso, o dei romanzi, sempre sloveni, di Boris Pahor o Alojz Rebula? E in quale dialetto? il triestino di Virgilio Giotti, Claudio Grisancich o Manlio Malabotta, il gradese di Biagio Marin o il rovignese di Ligio Zanini? Questi dialetti non sono affatto vernacolari, ma duttili, arcaizzanti e moderni, capaci di unire la vita comune e il verso. E non sono, insisterà poi Pier Paolo Pasolini, lingue ancillari, secondarie, ma assolute, occasionalmente corrette per rispondere alle esigenze della letteratura. La poesia non passa da una lingua maggiore a una minore, a un particolarismo di regione, di città o di quartiere, o peggio, a una mitica essenza di se stessa, e nemmeno solo a un lessico, ricco di echi veneziani, sloveni, croati, austro-tedeschi, oltre che di ellenismi e latinismi. Ogni poesia non ci mette forse all’ascolto di un’altra lingua straniera?
Quella che gli scrittori Ferruccio Fölkel e Carolus L. Cergoly chiameranno, in austro-tedesco, la Katastrophe, resa ineluttabile dalla Prima guerra mondiale, aveva già condotto alla disintegrazione dell’Impero: “L’agonia degli Asburgo fu lunga. La fine parve rapida. Il vessillo giallo e nero con l’aquila bicipite, emblema della Casa regnante, venne strappato. Evviva. Abbasso. 1382-1918.” Orfana, priva di industrie, tagliata fuori dal suo entroterra, dai mercati della Carnia e dai suoi ex-territori più lontani, Trieste muore giovane, con Francesco Giuseppe. O meglio, Trieste non riesce a morire. Lo psichiatra Franco Basaglia, molto più tardi, dirà: per rinascere, Trieste deve prima morire; ma si rifiuta di farlo.
Mentre il fascismo già regnava in Italia, la Francia scopre Ettore Schmitz, alias Italo Svevo, grazie a Paul-Henri Michel, che tradusse La coscienza di Zeno (Zéno, 1927) e Senilità (Sénilité, 1930) – bisognerà aspettare gli anni Sessanta prima di leggere i racconti e le novelle, e il 1973 per Una vita e gli scritti autobiografici. Poi, grazie all’instancabile lavoro di Mario Fusco, i tre grandi romanzi furono finalmente tradotti in modo compiuto. Come Zeno, che non sapeva scegliere e salvaguardava l’apertura verso il possibile attraverso finte sapienti e irresolutezze, Svevo commerciava in austro-tedesco, ma scriveva clandestinamente in italiano, e alcuni dei suoi personaggi, ultimi rappresentanti dell’Ostjudentum, evocano il pazzo meshuge. Conoscitore dei meandri dell’anima, poeta ironico e tragico, lucido e tuttavia mascherato, d’un soggetto ormai al crepuscolo, del disagio della civiltà e della crisi della borghesia, Svevo aveva insegnato a James Joyce un aspetto della sua città, quello di un’angoscia che prelude alla rinuncia, alla dissoluzione, la vita “nel compromesso fino al limite dell’autodistruzione”.
Dopo il 1930, è un lungo silenzio. Le tragedie lungo il percorso verso e durante la Seconda guerra mondiale si succedono: la promulgazione delle leggi razziali da parte di Benito Mussolini, il 18 settembre 1938, in piazza Unità d’Italia, davanti a una folla festante, in una città che contava allora la terza comunità ebraica più grande e influente del paese; la Risiera di San Sabba, l’unico campo di sterminio nazista nel Mediterraneo, dove ebrei, partigiani e oppositori politici, italiani e slavi, morirono in camere a gas, sotto i proiettili, a causa delle torture subite o con il collo spezzato da una pesante mazza di metallo; le foibe, cavità naturali nella pietra carsica dove migliaia di persone furono assassinate dai fascisti, ma anche durante operazioni organizzate dal maresciallo Tito per diffondere il terrore tra le popolazioni italiane della Venezia Giulia e dell’Istria, e per liquidare gli oppositori politici jugoslavi. Perché la guerra a Trieste non finisce nel 1945. La spartizione del suo “Territorio libero”, creato dal trattato di Parigi nel 1947, pone la città fino al 1954 sotto l’autorità anglo-americana, che scruta l’orizzonte, vicinissimo, dell’oltrecortina.