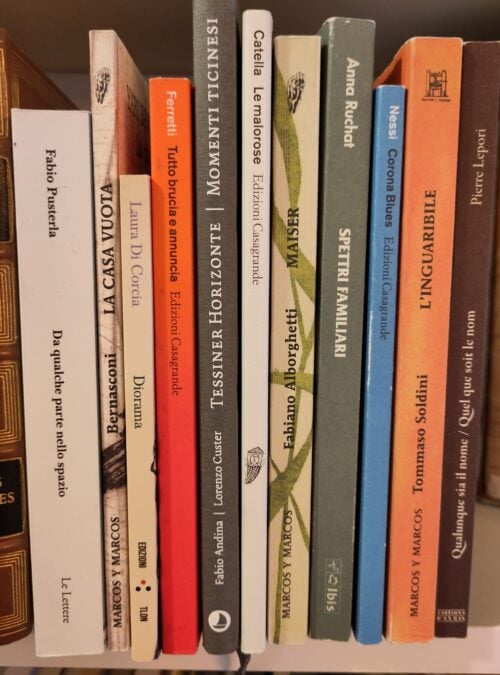Tradurre i dialetti italiani:
croce e delizia
Autore: Katherine Gregor, traductrice de l'italien vers l'anglais

Un giorno, allorché stavo lavorando alla traduzione in italiano di un romanzo, essendomi imbattuta in numerosi inserti dialettali, decisi di chiedere al mio editore di mettermi in contatto con l’autrice affinché mi potesse aiutare a comprendere delle espressioni che non riuscivo a trovare tradotte o spiegate in rete. La mia richiesta fu accolta con molta gentilezza.
Qualche settimana dopo, mi capitò di chiacchierare con l’editore italiano del libro che stavo traducendo. “Sai, quando ho chiesto i contatti dell’autrice”, mi ha detto ridendo, “sembravano un po’ preoccupati circa la tua conoscenza dell’italiano. Ho dovuto spiegare che i traduttori devono conoscere l’italiano, non tutti i dialetti della penisola”.
Dapprima fu il panico (“Oddìo! Adesso pensano che io sia un’incompetente!”), poi provai un sentimento di sollievo (“Grazie al cielo l’editore italiano li ha messi a posto”), infine prevalse una più calma riflessione. Era evidente che la persona che dubitava delle mie capacità di traduttrice non conosceva l’Italia, la sua lingua e la sua letteratura. Ma quante persone al di fuori dell’Italia – anche nel mondo dell’editoria – sono pienamente consapevoli del ruolo cruciale e viscerale dei dialetti, o lingue vernacolari, nella cultura italiana? Un’amica napoletana, oggi sessantenne, mi ha raccontato che, come la maggior parte degli italiani della sua generazione e di quelle a lei precedenti, è cresciuta bilingue: parlando italiano a scuola, al lavoro e in contesti ufficiali, e dialetto (napoletano nel suo caso) con la famiglia e gli amici più stretti.
Durante il mio primo viaggio a Milano, nel 2019, chiesi al portiere dell’albergo di farmi avere un appendiabiti in più. Adoperai la parola “stampella”. Dietro le spesse lenti degli occhiali, lo sguardo del portiere sembrò spalancarsi nel vuoto. “Una stampella?”, ripeté lentamente, con aria abulica.
“Sì, una stampella”, insistetti, chiedendomi se avessi chiesto una cosa che a Milano fosse illegale o immorale. Per appendere i nostri vestiti, aggiunsi in italiano.
Il portiere sembrò allora riscuotersi. “Ah, una gruccia”, disse, togliendosi gli occhiali per pulirne le lenti, probabilmente allo scopo di distrarsi dall’impulso di ridere sotto i baffi.
Né gruccia né stampella sono parole dialettali. Sono parole dell’italiano standard. Solo a Roma, dove sono cresciuta, stampella viene tendenzialmente usato per designare un appendiabiti (anche se il suo altro significato è: attrezzo ortopedico). A Milano, a quanto pare, stampella viene usato solo nel suo significato di attrezzo ortopedico. Insomma, mi ero imbattuta in un caso di incomprensione linguistica su base regionale anche nell’italiano standard.
Recentemente ho letto che al momento dell’unità d’Italia, nel 1861, si stima che solo il 2,5% della popolazione parlasse correntemente la lingua standard che chiamiamo “italiano”. Questo dato può spiegare perché, ancora oggi, un gran numero di scrittori italiani attribuisce ai propri personaggi parole, modi di dire e espressioni dialettali. Per quanto mi riguarda, la frequente presenza del dialetto, o vernacolo, nella letteratura italiana è una sfida – e un piacere – in più nel mio lavoro di traduttore letterario.
Il mio primo incontro consapevole con un dialetto italiano non romano è avvenuto con il venesiàn, un dialetto arguto, istrionico, schietto, che viene pronunciato a ritmo di mitraglia dai gondolieri e dai negozianti di Venezia. Li ascoltavo affascinata, riuscendo a distinguere solo le parole più strane, anche se mi innamorai subito della loro sonorità. Amante della commedia dell’arte, mi sono in seguito divertita molto a tradurre – per mio puro divertimento – brani delle commedie veneziane di Carlo Goldoni. Come traduttrice professionista, ho affrontato finora il piemontese, il sardo, il lombardo, il friulano e, soprattutto, il siciliano traducendo I leoni di Sicilia e i volumi seguenti. E ho imparato che il siciliano cambia, varia da zona a zona in questa isola di 25.711 kmq. Come mi ha spiegato Stefania Auci, l’autrice de I leoni, ciò che si dice a Palermo non si dice necessariamente a Trapani, e viceversa. Lo stesso vale per le altre venti regioni d’Italia. A Venezia la nebbia è caìgo. A Verona, a meno di due ore di distanza, è nèbia. Mi hanno da poco spiegato che il mais si chiama melgòt a Bergamo e furmintù a Brescia, anche se le due città distano 53 km l’una dall’altra e sono entrambe in Lombardia.
Mi sono a lungo chiesta perché, nel XX secolo e all’inizio del XXI, il dialetto sia ancora così spesso usato nella narrativa italiana. Penso che se un romanzo ha l’ambizione di riflettere, con i mezzi dell’arte, temi e aspetti della società italiana, non può ignorare il fatto che questa realtà sociale è tutta compenetrata di parole ed espressioni regionali. Forse perché l’italiano standard è più una lingua della comunicazione formale ed è perciò più attivo a livello cerebrale che emotivo. Storicamente, è la lingua franca che permette di comunicare con gli altri, con coloro che – si presume consciamente o inconsciamente – non possono capirti fino in fondo perché il loro orecchio non è sintonizzato con il ritmo del tuo cuore nella tua lingua. Il dialetto, invece, può trasmettere le tue emozioni a un pubblico cui non hai bisogno di spiegare tutto per filo e per segno, perché capiscono davvero – e non solo letteralmente – da dove vieni.
Nessuno può mettere in dubbio il mio amore per la lingua italiana. La parlo praticamente dalla nascita. Sebbene io traduca anche dal francese, che sento vicino al mio cuore quanto l’italiano, essendo in parte cresciuta in Francia, è stata la lettura dei libri di una scrittrice italiana che per la prima volta ha fatto nascere in me il desiderio di diventare una traduttrice di testi letterari. Tuttavia, la mia predilezione per l’italiano non mi impedisce di trovare spesso la prosa italiana un po’ didascalica e troppo scritta. Ben poco è lasciato all’immaginazione del lettore, quando vengono messi i puntini su tutte le “i” e ogni informazione è dettagliata fino all’inverosimile. E, pur essendo a volte costretta a rendere leggermente più sintetica la versione inglese per soddisfare le moderne orecchie anglofone, la maggior parte delle quali sottoscrive l’adagio di Polonio secondo cui “Brevity is the soul of wit” (la brevità è l’anima dell’ingegno), mi chiedo se questa tendenza all’eccesso di spiegazioni non derivi dall’ormai dimenticato, misconosciuto, ma ancora profondamente radicato senso dell’italiano come lingua di comunicazione piuttosto che di espressione personale. È una mia speculazione, ovviamente.
È senza dubbio vero però che, a mio avviso, la brevità e la concisione tanto apprezzate dai letterati anglofoni e francesi si trovano in abbondanza nei dialetti italiani.
Sebbene la mia famiglia non sia italiana, sono nata a Roma e vi ho trascorso metà della mia infanzia e adolescenza. Ancora oggi, a distanza di decenni, mi ritrovo a volte a usare quel poco di romanesco che conosco quando ho bisogno di esprimere qualcosa che mi viene dalle viscere. Grido Dajeee! quando tifo per una squadra (a volte anche per l’Inghilterra) mentre guardo le partite del mondiale con mio marito. Quando poi mi chiede se ha messo una quantità sufficiente di un ingrediente in un piatto che stiamo cucinando, spesso gli rispondo Avoja (in italiano: hai voglia, significa “più che sufficiente”). E temo che mi escano di bocca insulti romani poco eleganti quando guardo alcuni dei nostri politici britannici intervistati in un telegiornale, insulti che coinvolgono gli antenati dei politici suddetti. Quando parlo con i miei vecchi amici romani, la parola in romanesco, così malvista dai non romani, che la definiscono grossolana, salta fuori nel nostro discorso e gli aggiunge immediatamente colore e spezie – spezie che ti riscaldano. A volte, non c’è niente di meglio del suono del dialetto per trasmettere ciò che si prova davvero.
Se i modi di dire dialettali italiani sono talvolta difficili da trasporre nell’italiano standard, tradurli in inglese è un’impresa che farebbe gettare la spugna a Ercole.
Quando ho pensato a come tradurre il dialetto, ho scartato l’opzione di usare un dialetto regionale del Regno Unito, per evitare il rischio di creare associazioni incongrue nella mente del lettore. Un esempio è offerto, in proposito, dall’uso da parte di Stephen Sartarelli dell’italiano di Brooklyn per rendere il dialetto siciliano nei romanzi di Montalbano: sebbene le traduzioni di Sartarelli siano innegabilmente popolari, la sua scelta mi sembra che tolga qualcosa all’identità locale della vicenda narrata. Sostituire il dialetto della lingua di partenza con un dialetto inventato o con un idioletto della classe operaia mi sembra altrettanto rischioso.
InPer una cipolla di Tropea i dialetti aiutano a dare vita ai personaggi e a evocare i diversi aspetti della vita portuale. Ho deciso di sottolineare il fatto che alcuni personaggi parlano in dialetto lasciando alcune parole e frasi nella [lingua di partenza], ma permettendo ai personaggi stessi di ‘tradurre’, come quando Vercesi, annusando le cipolle rosse, dice:
“Bon odòr. Hanno un buon profumo”.
[Lo scrittore] Alessando Defilippi utilizza talvolta questa strategia, ad esempio:
“Dulsa” bofonchiò il maresciallo. “È dolce”.
Insomma, ho cercato di mantenere l’inclusione del dialetto originale a un livello tale da non diventare invadente.
Emma Mandley, traduttrice dall’italiano verso l’inglese
A differenza di quanto accadeva fino a poco tempo fa in inglese, i regionalismi italiani nella lingua parlata non tendono ad avere connotazioni di classe sociale. Sono semplicemente un segno di quello che, fino a un secolo e mezzo fa, era una realtà statale distinta, con un proprio modo di vestire, una propria cucina, proprie tradizioni e un proprio modo di parlare. Devo sempre ricordare a me stessa che questo tipo di premessa non è familiare ai lettori anglofoni, e in particolare britannici, la cui storia è quella di una secolare centralizzazione politica e amministrativa. Se scegliessi di trasmettere un dialetto italiano attraverso, ad esempio, il Liverpudlian o il Geordie, i lettori non potrebbero evitare di fare associazioni storico-culturali che sarebbero del tutto inappropriate per un romanzo ambientato in Italia. Nessuna espressione regionale inglese, scozzese o gallese potrebbe anche solo lontanamente catturare la cultura, il background e soprattutto il temperamento di un personaggio siciliano, romano, veneziano o milanese.
Nella mia traduzione di Via Gemito (Europa, 2023) di [Domenico Starnone] mi sono affidata a diverse strategie per catturare il dialetto napoletano. Ho scelto di lasciare in napoletano le oscenità più lunghe, in modo che potessero conservare la loro specifica diversità e musicalità; per gli epiteti sostantivi-aggettivi di uso frequente mi sono sforzato di evitare qualsiasi sottoinsieme culturale facilmente identificabile; per l’onnipresente frase sti cazzi mi sono affidata sia all’italiano sia all’inglese, a seconda di dove appariva nel testo (o prima o dopo la fantasiosa spiegazione della frase da parte del narratore); nei dialoghi, dove sarebbe stato molto facile usare lo slang, mi sono astenuta dall’usare parole come gonna, wanna, shouda ancora una volta per tenermi lontano da qualsiasi stereotipo. Ci sono molti modi di trasmettere ciò che significa essere napoletani, e l’americanizzazione del linguaggio di Starnone non è uno di quelli che approvo.
Oonagh Stransky, traduttrice dall’italiano verso l’inglese
Se dovessi tradurre un romanzo scritto o ambientato prima del XIX secolo, penso che potrei potenzialmente usare, con debita parsimonia, espressioni regionali inglesi usate in un’ampia fascia del Paese e non collegate a una specifica città o regione. Poiché finora ho tradotto soprattutto narrativa italiana del XX e XXI secolo, ho deliberatamente evitato di cercare corrispondenze tra idiomi dialettale italiani e le espressioni regionali inglesi.
Quando ho tradotto La cognizione del dolore [di Emilio Gadda] (The Experience of Pain, Penguin Classics, 2017), il problema del dialetto si è posto, fortunatamente, per un solo personaggio, il colonnello Di Pascuale che, ci viene detto nel capitolo 4, discende da una famiglia di origine italiana immigrata a Maradagàl (il paese sudamericano fittizio in cui è ambientato il romanzo) alla fine del secolo precedente. Il suo linguaggio è impenetrabile anche nell’originale italiano e risulta funzionale ad effetti espressionistici. La storia è raccontata dal narratore e le spacconate del colonnello forniscono un contorno comico.
Mi è stato d’aiuto il consiglio dell’eminente traduttore Michael Henry Heim, che ha suggerito di creare un dialetto unico attraverso una combinazione di contrazioni, errori grammaticali e simili, per produrre un modello di discorso che non avesse un’identità geografica distinta, ma che fosse comunque in grado di trasmettere informazioni fondamentali.
Nell’esempio seguente, il colonnello ha smascherato un falso invalido:
“ ‘ …. Guagliò, fernìmmola ‘na bbona vota !…. cu sta’ pazzïella d’ ’o sordo !…. Dàlle, dàlle…. e’ cuccuzielli devéntane talli…. Cca stare ‘e testimonia…. due testimoniu belli…. comme vo’ ’a leggia….’ (gli scritturali tacquero)….” [La cognizione del dolore, Adelphi, 2017, p. 120].
“ ‘… Okkay boy, stop’t here once and for’ll !… and dis madness ‘about you bin deaf !…. Tall sturies git longer ’n longr… den turn bad Now ’ere’s evidence…Two gud witnissis… jus’ as law ricuires…’ (the clerks fell silent)…” [The Experience of Pain, Penguin, 2017, p. 118].
Richard Dixon, traduttore dall’italiano verso l’inglese
A seconda del contesto dell’originale italiano, a volte opto per un’espressione colloquiale colorita e neutra dal punto di vista del tempo, del luogo, della classe e dell’età per trasmettere il messaggio in dialetto.
La madre di Oliva [in The Unbreakable Heart of Oliva Denaro di Viola Ardone, HarperVia], viene rifiutata da tutte le “lingue di forbice” della cittadina siciliana di provincia perché è calabrese. La sfida era come rendere l’abisso tra due dialetti, quando qualsiasi tentativo di trovare equivalenti regionali in inglese avrebbe portato con sé troppe connotazioni e sarebbe stato eccessivamente specifico dal punto di vista culturale (se avessi scelto due regioni del Regno Unito, per esempio, un lettore indiano, australiano o americano avrebbe potuto apprezzare le differenze?) Una volta stabilito che la madre mormora imprecazioni o urla alla sua famiglia in un dialetto calabrese che nessuno capisce quando è arrabbiata o frustrata – il che accade quasi sempre – la soluzione è stata abbastanza semplice: riflettere il suo carattere, il suo status sociale e il suo punto di vista nel discorso diretto e aggiungere al verbo riportare “mormorò in calabrese” o “urlò nel suo dialetto”.
Clarissa Botsford, traduttrice dall’italiano verso l’inglese
Di norma, e a seconda della quantità di dialetto presente nel romanzo che sto traducendo, sono propensa a lasciarne il più possibile nell’originale, in corsivo, immediatamente seguito da una traduzione o da una parafrasi. Troppi casi di parafrasi possono appesantire la versione inglese, quindi, per amore dell’eleganza, quando è assolutamente necessario, mi è capitato di aggiungere qualcosa alla risposta di un altro personaggio, in modo che la sua reazione renda più chiaro il significato delle parole pronunciate dal suo interlocutore. Se questa parola o espressione è usata molte volte nel testo originale, la parafraso o la traduco solo una volta e confido che il lettore ne ricordi il significato o consapevolmente o assorbendolo nella sua immaginazione.
Spesso vorrei che gli editori anglofoni non fossero così contrari alle note a piè di pagina, soprattutto quando un idioma dialettale è particolarmente colorito o si riferisce a un evento storico o a una fede religiosa. Tornando al tema degli insulti, quale sarebbe la traduzione accettabile per un copy editor anglofono del romano Mortacci loro? “Damn them”? Messaggio potente un paio di secoli fa, quando invocare la dannazione su qualcuno era il peggior destino possibile da augurare, ma oggi, diluito in un abuso verbale poco fantasioso, non riproduce affatto la creatività che sta alla base di Mortacci loro, che non è, in realtà, una maledizione, ma un’ingiuria con cui si offendono pesantemente gli antenati della persona cui ci si rivolge.
Un’altra mia espressione preferita in romanesco è È come cercà Maria pe’ Roma. “Like looking for a needle in a haystack” è un’espressione molto povera e non illustra affatto la ricerca di una donna di nome Maria in una città che è la capitale storica della Chiesa cristiana. So che quando leggo libri in una traduzione non inglese, accolgo con piacere queste informazioni in note a piè di pagina. Dopo tutto, leggere un romanzo non significa solo seguire la trama. Al giorno d’oggi ci sembra che le note a piè di pagina disturbino il flusso della lettura. Forse, se il budget editoriale ci permettesse di aggiungere qualche pagina in più al libro, potremmo prevedere l’inserimento di un glossario delle voci dialettali più frequenti, per i lettori interessati all’etimologia e alla storia della lingua.